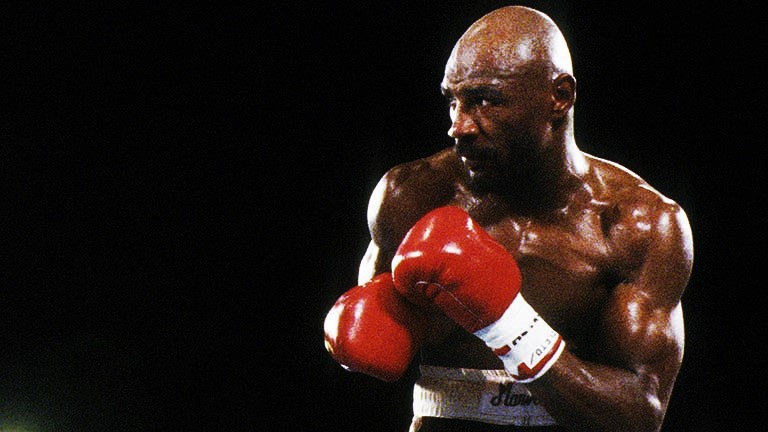C’è poco da esultare per il probabile naufragio del progetto Super League, affondato dalla inadeguatezza sostanziale e comunicativa degli stessi che lo hanno pensato.
La romantica rivoluzione digitale che per quarantotto ore ha spalato montagne di letame sulle corazzate pallonare continentali è solo la punta dell’iceberg: il calcio del Real, della Juve, del Milan, del Manchester United era già un bubbone ipertrofico, prima della “cura di fine mondo” della Super League, viveva di fluttuazioni azionarie, di speculazioni, di diritti televisivi venduti alle aste “truccate” delle Pay Tv.
E lo sapevano tutti.
Dalle vergini immacolate della FIFA ai sepolcri imbiancati dell’UEFA, fino ad arrivare a un De Zerbi qualsiasi, che oggi recita la parte del Masaniello con la casacca del Sassuolo, ma domani, con ogni probabilità, venderebbe l’anima sua e della sua settima generazione ai miliardi del fondo Elliott o alle scatole cinesi dell’Internazionale pur di sedere su una panchina prestigiosa.
È il calcio moderno, come lo chiamano con disprezzo gli Ultras.
Una roba che andrebbe governata da manager all’altezza, anziché da gentucola che compra i voti dei Paesi del Terzo Mondo pur di assegnare i Mondiali a Nazioni con poche o nessuna legge seria sugli appalti negli Stadi.
Gente che avrebbe dovuto lavorare per portare sempre più spettatori negli Stadi, parallelamente a una fruizione moderna del fenomeno-calcio a livello globale, spettacolo-sport, esattamente in questo ordine.
Lezioni da nessuno di “lorsignori”, per pietà.
La pandemia ha accelerato, nelle testa e nelle tasche dei Florentino Peres e degli Agnelli, quel processo di riforma della Coppa dei Campioni (romanticismo per romanticismo) al quale si lavora da anni, senza mai arrivare a una conclusione che contemperasse adeguatamente l’interesse economico dei padroni, la modernizzazione del fenomeno calcistico e la “puzza di piscio”, scusate il francesismo, dei cessi di ogni stadio, in ogni parte del mondo.
Il Covid-19 ha fatto nascere e morire la Super League, con l’unico merito di aver scoperchiato il pentolone dell’ipocrisia, dentro al quale sguazzano tutti quelli che hanno responsabilità di “governo” del calcio mondiale, generali di un esercito che sarebbe nulla senza l’indotto stramiliardario delle super sorelle, ma sarebbe ancora meno senza la dimensione “glocal” del tifo, della passione, degli stadi pieni, delle generazioni che si tramandano rituali e feticci di un amore inspiegabile, difficile da comprendere, resistente anche alle porcherie più evidenti, ben prima della ipotesi Super League.
Il Re è nudo, il pallone sgonfio e la base digitale degli spettatori e dei tifosi inorriditi segna una vittoria di Pirro.
La vera battaglia per salvare quanto di buono c’è ancora in questo mondo, parafrasando il dialogo fra Frodo e Samvise Gamgee nel Signore degli Anelli, deve ancora cominciare e vale la pena di combatterla, certo.
Provando, però, a non farsi guidare dal fariseismo di chi ha lucrato fino a ieri sulle storture del sistema e oggi lucida la lama della ghigliottina.
You’ll never walk alone, guys, ma fino a un certo punto.