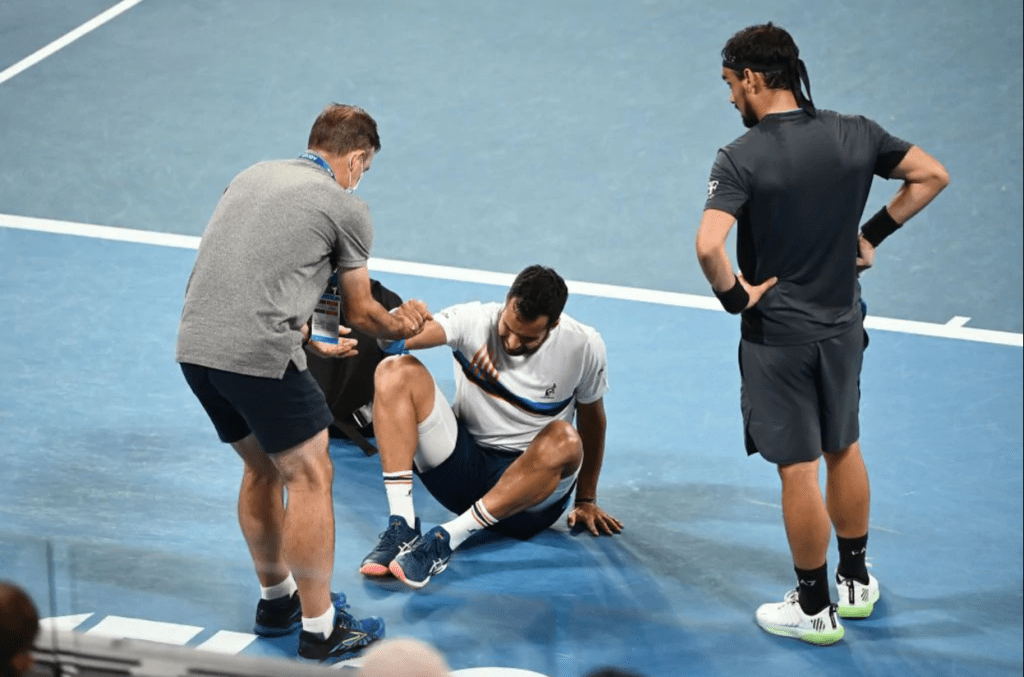È probabile che vi stiate chiedendo chi sia questo omone tutto nero con la maglia numero dieci.
E se ve lo state chiedendo vuol dire che il rugby non è mai stato il vostro sport, perché Dan Carter, trentottenne leggenda della palla ovale, sta a questa disciplina come Maradona al calcio, Nureyev alla danza, Von Karajan alla direzione d’orchestra.
Un mito con il Dieci inciso sulla schiena, come un tatuaggio maori, mediano d’apertura paradigmatico a livello mondiale, preciso, forte e tecnicamente pulitissimo, come e più degli straordinari interpreti di questo ruolo nella storia dei guerrieri in maglia tutta nera.
Mancino di rara precisione, fra palloni schiacciati in meta e piazzati al centro dei pali ha collezionato 1598 punti, vinto due Mondiali e messo il sigillo sui titoli continentali in tre Nazioni diverse: Nuova Zelanda, naturalmente, Francia e Giappone, buen retiro di fine carriera, prima del ritorno in Patria.
Una leggenda nella leggenda, in una squadra di marziani nella quale per emergere e indossare il mantello dell’immortalità bisogna davvero possedere la pietra filosofale.
E Dan l’aveva, trasformando in ovali d’oro ogni percussione dei portatori di palla, imbeccando i Centri, le Ali e persino qualche Pilone, perché nello sport del sostegno e dell’avanzamento in sincrono, l’apertura è un metronomo democratico, che non può fare differenza fra l’eleganza dei tre quarti e la rude essenzialità degli avanti.
Carter ha detto basta, alla soglia dei quarant’anni, con l’intento di godersi la famiglia, facendola finita con le nobili botte sul campo e restìo a sedersi in panchina, perché per lui il rugby è stato uno sport totale e totalizzante, e non riesce ad immaginare di allenare senza che questo significhi impegno e dedizione.
Chissà quanto tempo resisterà prima di ricominciare ad insegnare rugby, come è giusto che faccia un professore per vocazione e genetica. Quel che è certo è che nel momento stesso in cui ha svestito la maglia dei Blues, sua ultima squadra dopo l’avventura giapponese, si è trasformato in una Supernova, la più splendente fra le esplosioni stellari della Galassia Ovale.
Good luck, Mister Carter, and good-bye.